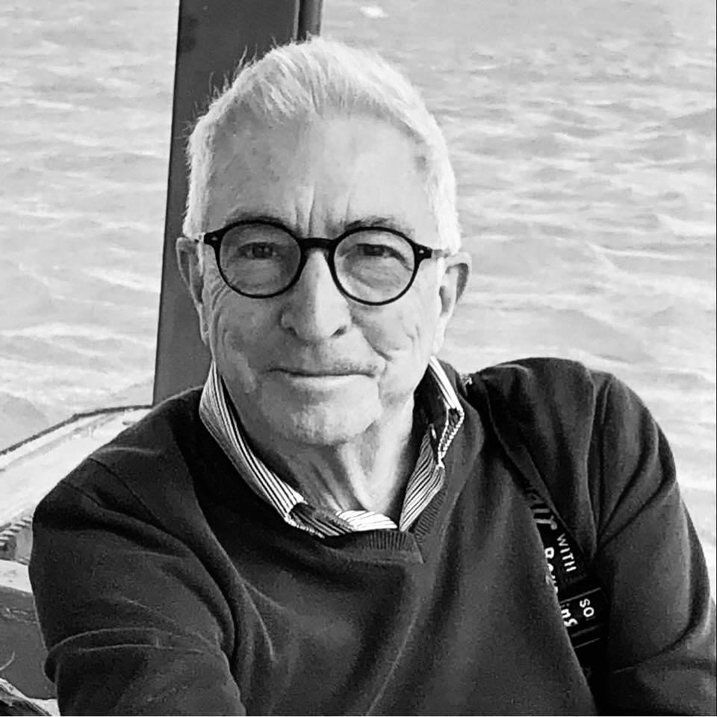25 aprile storia comune
Di Ennio Chiodi
«Prendendo la parola in questo consesso mondiale, sento che tutto, tranne la vostra personale cortesia, è contro di me: è soprattutto la mia qualifica di ex nemico che mi fa considerare come imputato». È il 10 agosto del 1946 quando Alcide De Gasperi prende la parola alla Conferenza della Pace di Parigi che doveva sancire premi e punizioni, nuovi confini e nuove divisioni, nell’Europa che sopravviveva al disastro politico, economico e uma- nitario provocato dalla seconda guerra mondiale. Il Presidente del Consiglio italiano, cattolico e democristiano, si presentava con il cappello in mano, come rappresentante di un Paese sconfitto e umiliato dalla sua stessa storia. «La mia posizione – ammette e ricorda De Gasperi – è per quattro quinti quella di imputato responsabile di una guerra che non ho fatto e che il popolo non ha voluto, per un quinto quella di cobelligerante». Una storia quindi rappresentata per buona parte da una guerra voluta dal regime fascista e perduta, e per una parte minore combattuta a fianco degli Alleati grazie all’impegno e al sacrificio della Resistenza partigiana. Il clima era tutt’altro che favorevole. De Gasperi, ribadendo il contributo dato dall’antifascismo italiano alla sconfitta della Germania nazista, prova a limitare i danni e in parte ci riesce. Cosa sarebbe stato del nostro Paese senza il contributo generoso della Resistenza, con tutte le sue contraddizioni e le divisioni che hanno portato anche a dolorose rese dei conti interne? Per la maggior parte dei Paesi alleati, come l’Italia fascista, della Germania nazista, è finita decisamente peggio: mutilati, occupati e “spartiti” tra le grandi potenze vincitrici. Sono davvero sempre più incomprensibili le polemiche ideologiche, le ripicche infantili, che accompagnano ogni anno le celebrazioni del 25 Aprile. La Festa della Liberazione, decisa nel ’46, è stata istituita nel ’49 da un governo che oggi potremmo definire di “Centro Destra”, con liberali e laici, ma senza i comunisti. L’intento è quello di “segnare”, di ricordare, né più né meno, la fine della guerra e della feroce occupazione nazista – perché di questo si trattava – e il crollo di regimi totalitari, razzisti e sanguinari. Ostinarsi a non riconoscere il valore e il senso di quella giornata, di quella festa che fu e dovrebbe essere “di popolo”, significa negare tutto questo. Impadronirsene, facendone strumento di costante lotta politica e ideologica e rivendicarla come retaggio identitario solo di una parte, significa non volerla consegnare compiutamente alla storia come patrimonio comune e rinnegare la costante, faticosa, ricerca dell’unità nella lotta al nazifascismo, fondamentale per la successiva crescita democratica del Paese.
enniochiodi [at] gmail.com